Viaggiando tra passato e presente in questi giorni di Natale, finalmente libero di meglio organizzare la mia vita quotidiana, rifletto a partire dalle pagine che Pietro Citati dedicò al grande Lev Tolstoj e al suo Guerra e pace, faticosa lettura giovanile di cui oggi comprendo meglio il pensiero.
Il Principe Andrej, che ha sempre preteso di guardare al mondo con i parametri della sola ragione, sul punto di morire vede finalmente una luce diversa e dà un senso al mistero della vita contemplando il cielo. Durante la battaglia di Austerlitz, che nel 1805 vide Napoleone trionfante contro i russi alleati degli austriaci, si è scagliato sul nemico in un impeto irrazionale, per poi ritrovarsi a terra, gli occhi rivolti al cielo, appunto, mentre, come in un incubo, sale dentro il terrore di essere calpestato dai piedi dei soldati in fuga. Un terrore che si diluisce a poco a poco e che scompare alla vista di quell’azzurro cielo che ha squarciato le nubi tutt’intorno. E’ una visione divina la sua? Forse. Certo ad Andrej pare di vedere l’infinito come non l’aveva mai osato vedere, e si prepara alla dipartita, finalmente libero di riporre in un cantuccio l’ottusa razionalità che ha accompagnato i suoi giorni.
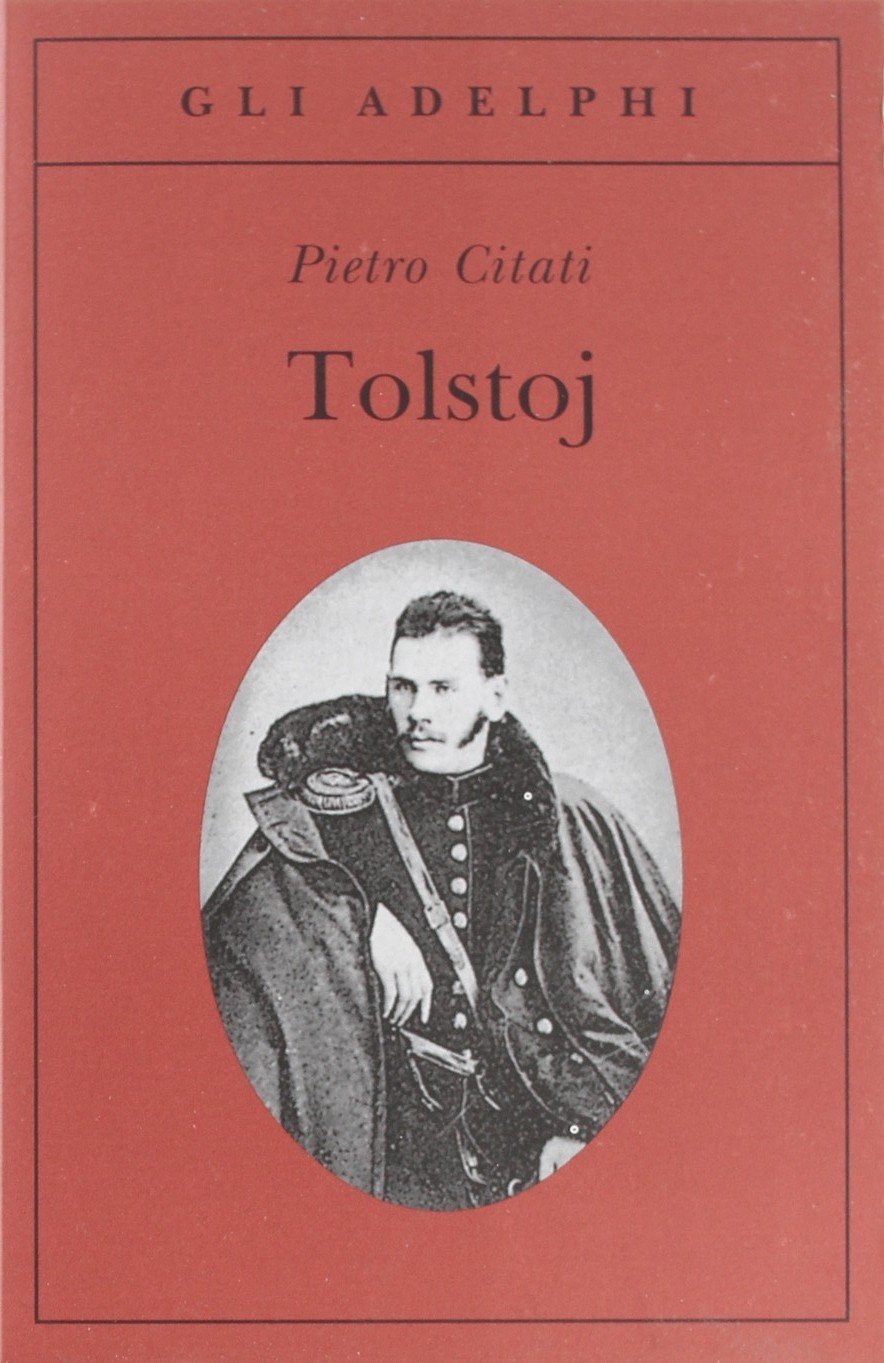
E’ una visione così lontana dai nostri tempi confusi quella che Tolstoj rappresenta attraverso gli occhi nuovi del Principe Andrej, che ripercorrendola mi ha provocato un brivido intenso. Quanto noi contemporanei sappiamo guardare al cielo? Quanto siamo in grado di portare la nostra mente oltre il “qui ed ora” spingendoci verso l’infinito? Certo, il “bel mondo” che ci restituisce Tolstoj in Guerra e pace è spesso frivolo e superficiale, intriso com’è di quel teatro della vita dove ognuno recita la propria parte (e mi chiedo tuttavia, il mondo del falso è veramente falso?), ma quanto dolore, quanta sofferenza, infine quanta grandezza si nascondono dietro quelle pagine insistentemente mondane! Sul versante cinema l’equivalente di questa grandezza la vedo ne Il Gattopardo di Luchino Visconti, traslato dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi da Lampedusa; ed è tutta nel prolungarsi del gran ballo palermitano, con il Principe di Salina che attraversa stanco e impaziente i saloni sontuosi di Palazzo Gangi visitati con occhio documentaristico dal grande regista milanese. Visconti e il Principe di Salina diventano infine una sola persona, che, non senza ironia, guarda con disincanto a quel mondo fatuo e ormai fuori dal tempo.
Sì, grandezza. Una grandezza che per il Tolstoj di Guerra e pace apparentemente è tutta in un tempo vissuto con i piedi ben piantati nelle cose terrene, salvo poi cercare una via di fuga nel desiderio esplicito di volare, come vorrebbe la sensuale Natasha, uno dei personaggi più luminosi del romanzo. E penso a come la realtà possa essere percepita diversamente in epoche diverse, sebbene nel corso della Storia l’animo umano sia sostanzialmente lo stesso. La realtà, insomma, si palesa soprattutto nella percezione del tempo in uno spazio ben definito dove convivono vita quotidiana e desideri, e come vedo piccoli noi contemporanei, che gli spazi fisici e mentali li teniamo in gran parte occupati dalle piccole incombenze quotidiane!
A volte penso al tempo ottocentesco con un senso di vertigine. E se poi quel tempo mi arriva attraverso i grandi romanzi russi di Dostoevskij, di Gogol, anche di Cechov, e naturalmente di Tolstoj, la vertigine sale. I paesaggi che vengono restituiti da quella grande letteratura, estivi o invernali che siano, sono paesaggi dell’anima, dove la solitudine si fa più forte per via del dilatarsi temporale e con esso degli spazi stessi.
Un tempo lento, talvolta asfissiante nel suo tenersi largo, che sia quello di uno Zio Vanja o di un Ivan Karamazov, in cui rispettivamente allignano l’incapacità di essere felice e un angosciante senso del nulla; esistenze nel fondo negative, che tuttavia restituiscono una condizione umana più profonda, universale oltre che struggente. Così come è anche in Tolstoj, sebbene in modo più sfumato. Indimenticabili le pagine di Guerra e pace in cui, come ci ricorda Citati stesso, sempre la bella e inquieta Natasha si annoia nel corso di una mattinata che non finisce mai. Vaga per la grande casa di famiglia in cerca di qualcosa o di qualcuno che possa restituirle un senso al vuoto che lei, giovane donna vitale e seducente, sente dentro. Eppure è proprio un incombente senso del vuoto a donare pienezza a certi personaggi di Tolstoj: l’ansia di vita in quello spazio/tempo sospeso tutto ottocentesco, conduce infine a sentimenti più umani e non per questo meno grandi, direi a una maggior pienezza della vita stessa. Si soffre? Certo! Ma è proprio in quella sofferenza che scaturisce da tempi e spazi dilatati e ingovernabili, fino ad alimentare un senso di solitudine al cospetto dei propri simili (la grande recita della vita) come di fronte a Dio (l’impotenza di fronte all’ignoto), che si può trovare l’infinito.
C’è una forte spiritualità dietro al gran teatro della vita che accompagna il lettore di Guerra e pace; spiritualità che noi contemporanei, occupati da mille faccende in spazi e tempi sempre più angusti (malgrado la globalizzazione), fatichiamo a percepire. Al punto che non si riesce più a pensare quanto la tanto sbandierata realtà, dove la nostra testa non sia capace di sfidarla con quel groviglio di sentimenti che sono le speranze, i desideri, l’anelito a qualcosa, in sintesi, il guardare oltre noi stessi, è ben poca cosa se il nostro cuore non è gettato oltre quell’ostacolo che è la vita stessa con tutte le sue piccoli e grandi incombenze quotidiane. E mi viene in mente quel pastore nei dintorni di Matera, il quale nel secolo scorso ricoverava le sue pecore in una grande grotta che si rivelò poi essere una chiesa paleocristiana ricca di dipinti bizantini raffiguranti Gesù, la Madonna e i santi, oggi conosciuta come Cripta del Peccato Originale. Raccontò agli archeologi increduli quell’anziano uomo costretto a vivere in solitudine a causa del suo lavoro, che ogni sera prima del sonno, aiutato da una torcia, si beava di tutta quella bellezza. Il nostro pastore, insomma, rimaneva poeticamente in bilico tra pezzi d’arte sacra abbandonati a sé stessi dall’incedere della Storia e incombenze ben più pratiche dovute al suo umile mestiere. Oltre la poesia di quel racconto in prima persona, c’è un insegnamento: “alto” e “basso” devono saper convivere se si vuol dare un senso alla vita; l’ho capito realizzando documentari per tre decenni, stando in ascolto di persone diverse tra miti, racconti e fatti reali. E poi basta guardare alla realtà con un po’ di poesia per salvarsi.

La realtà, appunto, che infine è tutta in quello che sappiamo e vogliamo vedere. E che se percepiamo sensuale o drammatica o altro, è perché palpita dentro di noi, non solo a causa del nostro carattere o stato d’animo, ma anche per via del luogo e dell’epoca in cui viviamo, come ben ammoniva il nostro Cesare Zavattini.
Sì, avvicinandoci un po’ più al tempo presente, è proprio il grande ZA ad aprirci gli occhi. Quello Zavattini che non esisterebbe se non fosse appartenuto mani e piedi alla sua Luzzara, nella Bassa reggiana; piatta e sfuggente, in estate a causa della foschia, in inverno per la nebbia; condizioni atmosferiche che hanno sempre spinto la sua gente a guardare oltre un orizzonte indefinito, fino a traslare la propria “folle” appartenenza territoriale nelle utopie e nelle pratiche della politica e ancor più nell’arte di un Ligabue come dei pittori “naif” cari allo stesso ZA.
In un reportage tedesco dei primi anni settanta, vediamo il grande Cesare ormai anziano condurre due giovani fino alla casa luzzarese di famiglia che ha appena acquistato. I ragazzi portano sulle proprie spalle i pezzi del letto matrimoniale appartenuto ai genitori di lui, che è riuscito a scovare in una cantina dov’era abbandonato da decenni. Ed è in quella riappropriazione, certo non solo materiale, che noi spettatori diamo un senso al tempo, e con esso ai luoghi in cui scorre la vita stessa: solo (ri)trovando l’appartenenza spazio-temporale, sia fisica che spirituale, a un luogo, comprendiamo che, di passaggio come tutti, al pari dei nostri genitori e dei nonni e degli avi, siamo destinati a perpetuare il ciclo della vita. Capite voi stessi che l’inquieta “Bassa zavattiniana” non è poi così lontana dalle steppe infinite della Russia ottocentesca care ai suoi grandi scrittori e al loro saper guardare oltre la realtà.
Buon anno! Felice 2023 a tutte/i voi!
